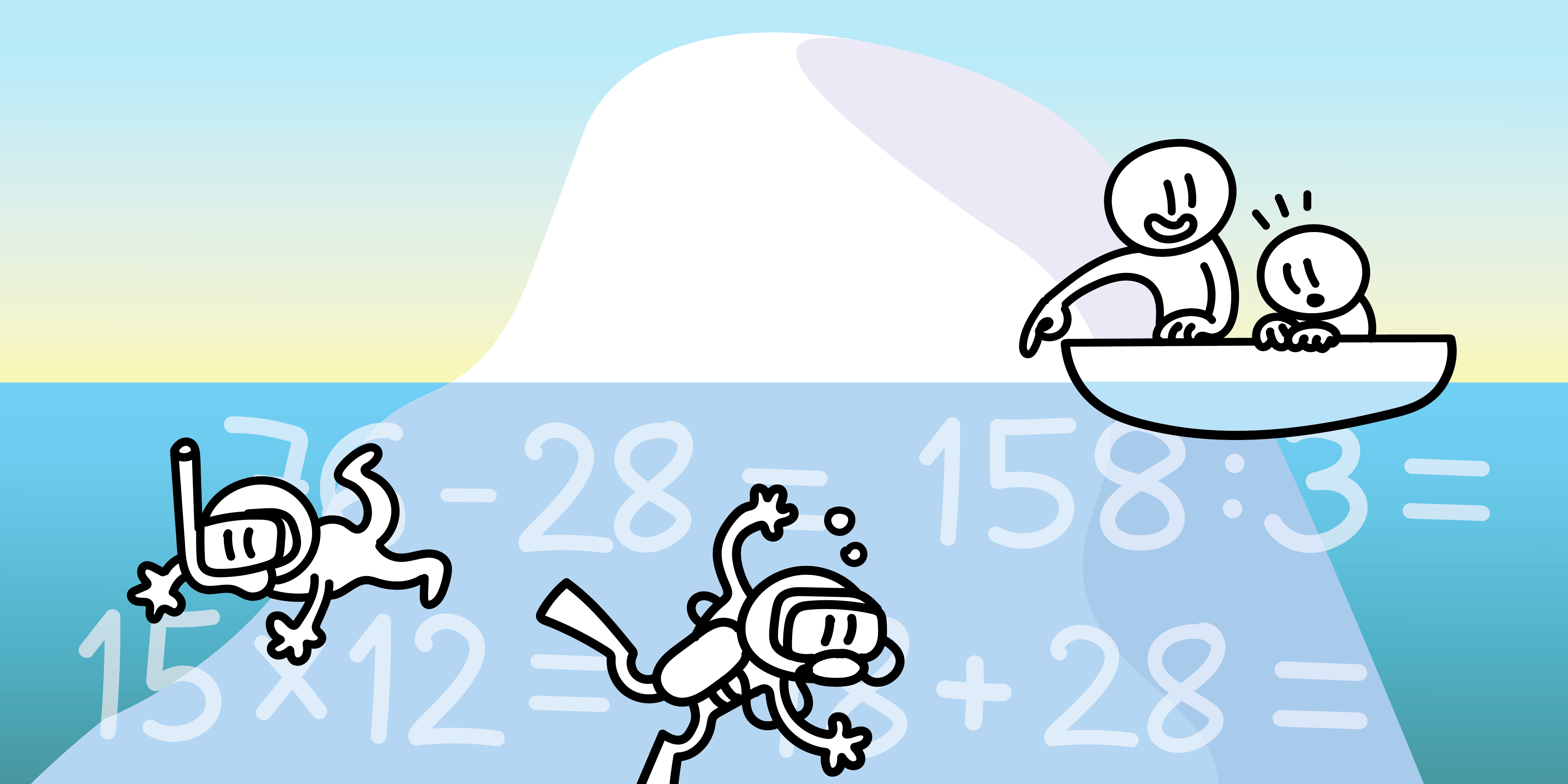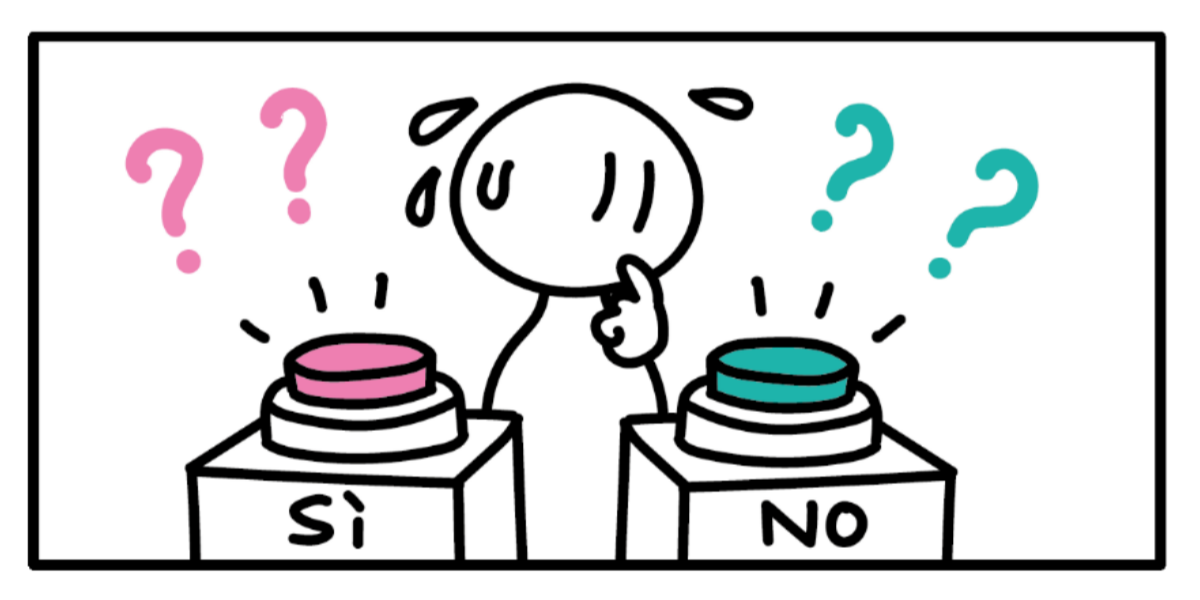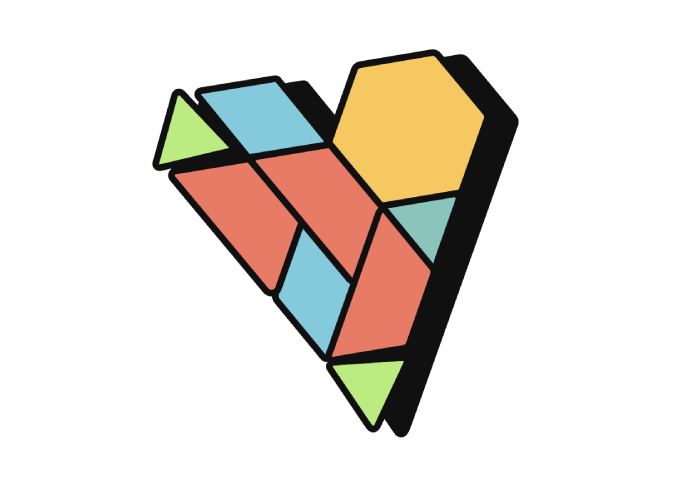E se a scuola aveste dovuto frequentare un corso d’arte in cui vi è stato insegnato solo come dipingere una staccionata? E se non vi avessero mai mostrato i dipinti di Leonardo da Vinci e Picasso? Questo vi farebbe apprezzare l’arte? Ne dubito. […] Certo, sembra ridicolo, ma è così che si insegna la matematica, e quindi per la maggior parte di noi diventa l’equivalente intellettuale di guardare la vernice asciugarsi. Mentre i dipinti dei grandi maestri sono facilmente reperibili, la matematica dei grandi maestri è chiusa a chiave.
Si tratta di una delle prime riflessioni condivise da Edward Frenkel, dottore in matematica presso l’Università di Harvard, nel suo bestseller Love and Math: The Heart of Hidden Reality (2015). «Se non sei un matematico, questo libro ti farà desiderare di esserlo», riassume Nassim Nicholas Taleb. Nel libro traspare la stretta relazione tra il «fare matematica» e il viaggio della vita, tra la matematica e l’arte. Come sottolinea, ad esempio, il grande matematico britannico Godfrey Harold Hardy in A Mathematician’s Apology (1940):
Perché questa visione della matematica è così poco diffusa? Una delle tante ragioni è che molte delle persone che si dedicano alla didattica della matematica provengono dal mondo della scienza, e questo è molto arricchente, ma comporta un importante contrappunto…
Cos'è la matematica?
«Uno strumento». Questa è la risposta di molti insegnanti di matematica (che di solito provengono da ambienti scientifici non matematici) alla domanda «Che cos’è la matematica per te?».
Sì, la matematica è molto utile in diversi campi, ma è molto più di uno strumento. È fine a se stessa e un mondo eccitante per coloro che la amano. È un modo di fare e di vivere che ha sempre e ovunque contribuito a formare il patrimonio culturale dell’umanità. Per rompere con questa concezione utilitaristica, è necessario diffondere una visione per cui la matematica brilla di luce propria.
Questa concezione della matematica descritta da Ujué Etayo, vincitore del premio José Luis Rubio de Francia 2021, è quella che vogliamo trasmettere ai nostri alunni. E come possiamo farlo? Attraverso le persone che vivono la matematica in questo modo: persone appassionate, che vivono, che dubitano, che sbagliano. Persone che possono diventare esempi per gli adolescenti.
Il viaggio di Sam
Il viaggio di Sam è una serie animata pensata per le lezioni di matematica della scuola secondaria di primo grado che mira a trasmettere questa visione più umanistica della matematica e che è stata creata con l’intento di rompere una falsa credenza profondamente radicata nella nostra società: «La matematica è solo per pochi eletti».

Attraverso Il viaggio di Sam, spieghiamo la vita di grandi personalità matematiche con l’intento di far capire a studenti, insegnanti e famiglie che tutti possono far parte del bellissimo mondo della matematica. Questa serie animata dovrebbe essere da apriporta per tutti quegli alunni che vogliono addentrarsi nel mondo della matematica da altre discipline (illustrazione, letteratura, storia…). E viceversa: anche la matematica può diventare la porta d’accesso ad altre discipline.
Contesto storico e referenti
E come scegliamo queste personalità matematiche per guidare il percorso dei nostri adolescenti in classe? Pensiamo ai grandi personaggi della storia. Persone che hanno dovuto affrontare situazioni difficili. E sono andate avanti… o no, ma hanno comunque lottato. Persone che hanno vissuto la matematica in modi diversi: come un rifugio, come una distrazione, come la ricerca della verità, come il modo di relazionarsi con altre persone, ecc. Persone che hanno messo in questione la norma. Persone rivoluzionarie.
Una di queste persone è, ad esempio, la grande matematica francese Sophie Germain (1776-1831). Essere adolescente nel bel mezzo della Rivoluzione Francese non dev’essere stato facile. Ancor meno se mostravi un certo interesse nei confronti di questioni intellettuali. Sembrava quasi impossibile che Sophie Germain riuscisse a studiare matematica. Persino i suoi genitori, che volevano proteggerla dal disprezzo e dalla sofferenza che le sarebbe toccata per mostrare un tale interesse nei confronti della matematica, fecero del loro meglio per toglierle questo pensiero dalla testa. Ma nulla riuscì a fermare Sophie. Finse di essere uomo (firmava i suoi articoli come Monsieur Le Blanc) e dovette affrontare i pregiudizi e gli stereotipi dell’epoca. Dopo anni di sforzi e lotte, nel 1816 divenne la prima donna a vincere un Grand Prix dell’Académie Royale de France. E come se non bastasse, fu la prima a dimostrare l’ultimo teorema di Fermat (1630) per un grande gruppo di numeri.

Oggi Sophie è ricordata per la sua grande determinazione. Il suo coraggio e la sua perseveranza hanno ispirato tantissime persone. Magari finiranno per ispirare anche te. Ecco come Cheryl Bardoe rivendica il ruolo di Sophie Germain nel suo racconto Nothing stopped Sophie. Vogliamo seguire i suoi passi. Anche noi vogliamo rivendicare il ruolo di personaggi come Sophie Germain, raccontare le loro storie. Recuperare le loro lotte e i loro conflitti; i loro successi, ma anche i loro fallimenti. Se i nostri alunni hanno la possibilità di incontrare persone come Sophie Germain, avranno anche l’opportunità di seguire le sue orme.