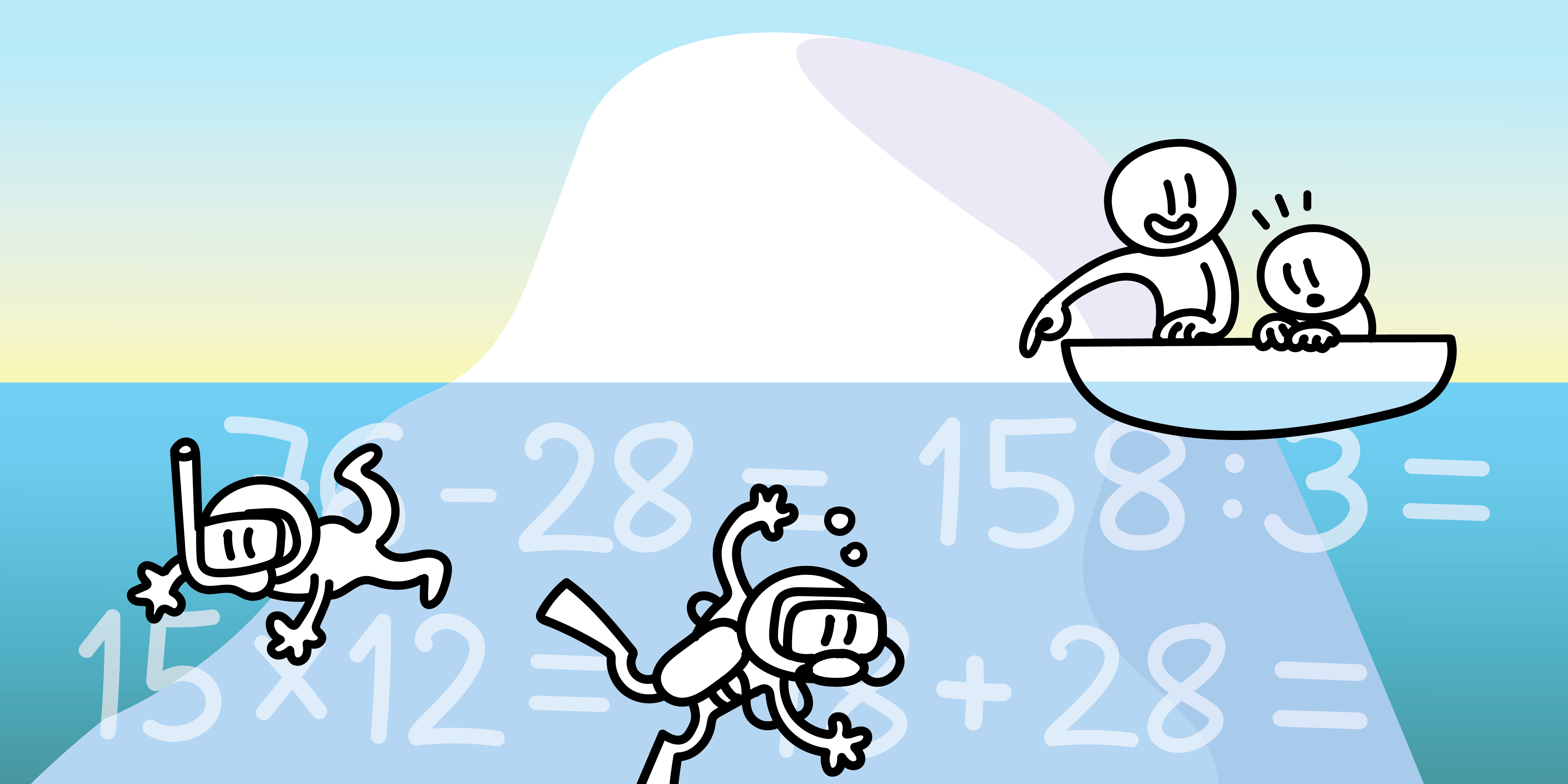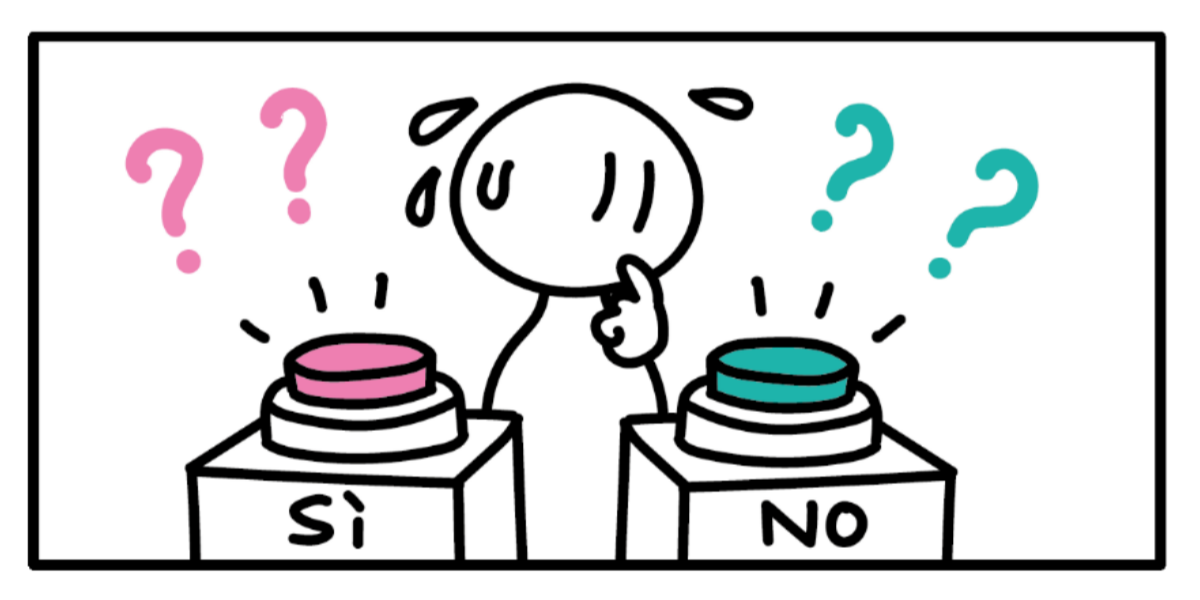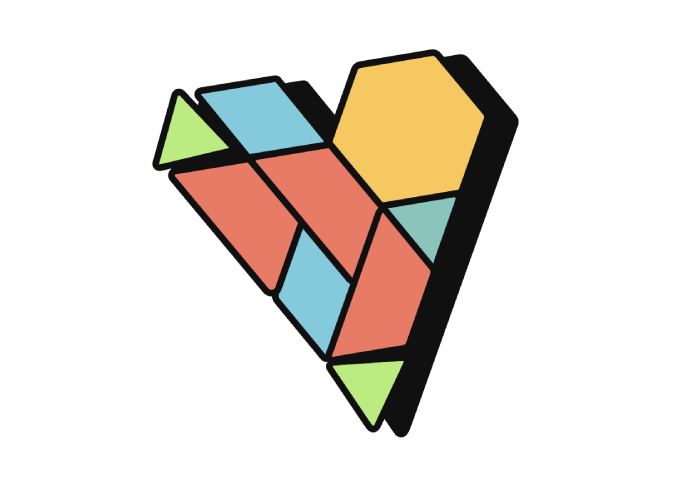Ricordate le lezioni di matematica di quando andavate a scuola? Come vi sembravano? In molti casi, a lezione gli alunni «imparavano» formule in modo poco chiaro, senza capirne il perché. Durante le lezioni, gli alunni non facevano altro che memorizzare nozioni in modo meccanico. Ma, proprio come chiariamo nell’articolo esercitarsi o non esercitarsi, ripetere fino a memorizzare non vuol dire necessariamente imparare.
Fortunatamente, esiste un altro tipo di lezione di matematica: quella che si svolge in un ambiente accogliente, in cui gli errori sono benvenuti e in cui si celebra la partecipazione di tutti, in cui non si lavora solo sui contenuti (numeri, geometria, ecc.), ma anche sulle competenze (ragionamento, risoluzione di problemi, ecc.). Lezioni in cui gli alunni vedono il mondo con gli occhi della matematica.
Per incorporare le competenze in classe, in una lezione di matematica ricca si lavora su di esse sempre insieme ai contenuti. Non sorprende quindi che sempre più insegnanti trovino utile un insegnamento più basato sulle competenze. Hanno capito che la base della conoscenza è che gli alunni imparino comprendendo, non ripetendo.
Attività per competenze e problemi di matematica
Un’attività per competenze è un’attività che mette al primo posto le competenze matematiche, cioè come si impara la matematica. In genere, l’attività parte da un problema, una domanda, una sfida per la quale non abbiamo una strategia predeterminata per risolverla.
Una situazione contestualizzata tradizionale (ad esempio: «Su un autobus viaggiano 17 persone e a una fermata ne salgono 4. Quante persone ci sono adesso?») non è necessariamente un problema, perché di solito per rispondere basta eseguire dei calcoli ben definiti, che non rappresentano una sfida. Questo non significa che non si debbano più proporre situazioni contestualizzate in classe. Sono essenziali per lavorare sulle operazioni aritmetiche di base, sulla comprensione della lettura e sui collegamenti con la vita quotidiana.
A lezione…
Immaginiamo una classe in cui l’insegnante prepara un’attività con carte con numeri da 1 a 9 e chiede agli alunni di prendere due carte e di sommare le loro cifre. Dopo aver ripetuto un po’ di esercizi, l’insegnante domanda: «Se prendo due carte a caso, che risultati posso ottenere?». A questo punto, gli alunni devono rendersi conto che esiste più di una soluzione e devono pensare a strategie per trovarle tutte senza dimenticarne o ripeterne nessuna.

Questi tipi di approcci contengono implicitamente le idee di base del processo di Risoluzione di problemi (comprensione dell’enunciato, elaborazione di strategie di pensiero sistematiche ed esaustive, verifica della soluzione, ecc.) e, a differenza delle situazioni contestualizzate, non possiamo automatizzarli. Fare matematica vuol dire creare, immaginare, cercare strategie… e divertirsi scoprendo il mondo!
Quindi, vediamo che la gestione dell’insegnante è molto importante perché i bambini imparino a porsi delle domande. È per questo che bisogna promuovere la creazione di un ambiente di risoluzione di problemi in classe. È necessario creare situazioni aperte in cui gli alunni possano analizzare ciò che succede, e andare oltre. Un esercizio che stimola gli alunni a porsi domande, è un esercizio che sta funzionando bene.
Siamo noi insegnanti, in quanto referenti, a dover generare queste situazioni e a far sì che le domande abbiano un ruolo fondamentale nel percorso di apprendimento degli alunni. E, sopratutto, dovremmo apprezzare ed esaltare quei momenti in cui gli alunni ci pongono delle buone domande. Nell’articolo La domanda a lezione di matematica spieghiamo qual è il ruolo dell’insegnante all’interno di questo nuovo paradigma educativo.